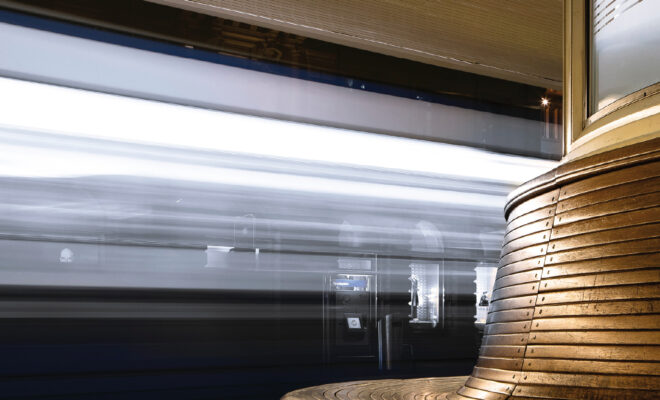“Tutto ciò che siamo stati”, un viaggio dal passato a se stessi

Olimpia De Girolamo con “Tutto ciò che siamo stati” (Gabriele Capelli Editore, pp. 127 pagine, euro 16) è al suo esordio letterario, per quanto già attiva in ambito teatrale.
“La gente di queste parti. Se mi sentissero, me ne direbbero di tutti i colori. E avrebbero pure ragione. Sono anche le mie parti, queste, solo che da qualche anno mi piace recitare la scena di quella che ha rotto col passato, che si è evoluta culturalmente, riuscendo a mascherare con grazia la naturale inclinazione alla malinconia del vivere. So bene, però, che è sempre e soltanto una l’evoluzione che siamo chiamati a compiere a questo mondo. Quello dalle nostre famiglie.”
Anna sta tutta, o comunque in larga parte, in queste righe. Lei che ha tessuto la sua fuga da Napoli, dalla famiglia, da un groviglio di fatti che ha preferito scansare invece che chiarire. Eppure a un certo punto Anna deve tornarci a Napoli, e lo fa così come se n’era andata: trafelata, ansiosa, guardinga, a disagio. Sì, in quella che è la sua città, la casa in cui è nata e in cui preferisce non dormire, scegliendo un B&B. Anna fa ritorno dopo vent’anni perché il padre è scomparso, lasciando una lettera oscura che pare solo lei possa decifrare. In effetti ci riuscirà, addentrandosi nei meandri di una Napoli sotterranea, ripercorrendo materialmente e mentalmente percorsi del passato e (ri)trovando una parte importante di sé.
“Ah, già, il quartiere. A Napoli il quartiere è depositario della voce di tutti. Voce ‘e popolo, voce ‘e ddio, dice un antico proverbio di queste parti. Non c’è bisogno di indagini della polizia. Il quartiere sa tutto prima che si trovi ogni prova, le prove le crea, le inventa (…) fa diventare vera ogni cosa che narra. (…) Più le parole sono grosse, pesanti e colorate, più chi le ascolta crede. Il quartiere, quindi, stava in qualche modo decidendo persino il motivo del mio temporaneo ritorno a casa.”
Il ruolo del quartiere e della città è cruciale. Quei muri e quelle crepe che sanno tutto, quel costruire una cosa dentro l’altra come se passato e presente si compenetrassero senza mai seguire una linea retta. Una città che ti assorbe e rapisce senza pietà, in cui la lingua madre torna, per Anna, come una punizione. La città che preferisce immaginare, suppore, ma non verificare. Che vede, ma sceglie di tacere: i dolori, le violenze, il degrado.
“Penso che, come le pietre messe assieme per caso, eravamo destinati a stare scomodamente nell’esistenza, senza mai un momento di abbandono e di calma.”
Napoli protagonista, ma non lo è di meno la famiglia. Una di quelle fatte di distanza, mutismo, musi lunghi, con solo sporadici exploit a cui Anna e il fratello Attilio si attaccano, bisognosi di attenzione. Un padre immobile e una madre capace, con un solo indice puntato, di cancellare i 40 anni di Anna e farla tornare quella bambina silenziosa di un tempo. Crescere male perché forse i propri genitori sono cresciuti peggio.
“Vorrei aver imparato a fare abbracci, vorrei che mi avessero spiegato che avere paura non è un delitto, che le cose brutte possono sparire se ti tieni stretto a qualcuno di cui ti fidi.”
Anna, col suo ritorno a Napoli, risana vecchie colpe. Soprattutto, le contestualizza e le guarda in prospettiva, quella di una bambina che non può essere consapevole fino in fondo di ciò che dice e fa, che avrebbe avuto bisogno di essere guidata. Forse è questo il momento dell’età adulta: riconoscere gli errori e capire che nonostante tutto, un modo per andare avanti si può trovare.
Laura Franchi