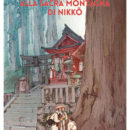“Trascendi e Sali”: lo spettacolo di Bergonzoni è rapsodia stellare

Una voce fa il suo ingresso, è una mitraglietta che spara comicità fin dal primo minuto, non lo vediamo Alessandro Bergonzoni, ma scorgiamo i suoi piedi muoversi per alcuni minuti avanti e indietro su un’impalcatura di metallo. È questo il curioso avvio di “Trascendi e Sali”, uno spettacolo “risarcimento”, come lo definisce lo stesso autore bolognese, risultato di una doppia regia divisa con Riccardo Ridolfi, in scena al Teatro Vittoria di Roma fino al 28 novembre. Un raffinato lavoro “a scomparsa”, dove il pubblico è spinto a chiedersi “l’inchiesto”. Potremmo dire che “esce dal seminario, ma non perde la vocazione” per un teatro autentico Bergonzoni che si palesa con la sua chioma grigia, una giacchetta bianca, pantaloni della tuta e scarpe da lavoro. Si mostra per quello che è, un operaio della parola, lui che da anni la esplora, la stravolge, assegnandole sempre un posto di rilievo nel discorso, il posto di chi sa perfettamente che sul linguaggio si fondano le nostre esistenze.
Le frasi attraversano viaggi di senso interstellari, frenetiche, coinvolgenti, capaci di provocare un coacervo quasi impensabile di riso e riflessione in chi le ascolta. Eppure non vi è superbia nella sua presenza scenica, il pregio di questo attore-autore è quello di salire sul palcoscenico e di trascenderlo, nascondendosi dietro alla stessa sostanza del suo dire, come quegli autori consci di quanto amare la parola sia una strada difficile, la parola non come strumento, ma come misura di uno spazio e di un tempo. E questo suo profluvio di metafore, traslitterazioni, analogie, crea ininterrotte fratture in cui si infila un “sur-reale” percosso dall’affilatissima ironia della lingua. Si passano in rassegna i guasti e i buchi neri del nostro quotidiano, ce n’è per tutti, in primis Stato e Religione che dovrebbero sostituire a “disegni di legge e Bolle papali, più esercitazioni di perdono a sorpresa”. Tocca poi alla cara Educazione che perde colpi, scivolando nel paradosso e pretendendo troppo dai suoi figli: Torna a mezzanotte massimo all’una. Sono traumi. Il figlio si chiede perché io a mezzanotte e Massimo all’una. Che cos’ha lui meglio di me? Non recita solo una parte Bergonzoni, o meglio, le fa tutte, anche quella dello spettatore. Ci sono delle quintessenze ai lati del palco, i “semi-nascosti” (ancora una volta un gioco linguistico), quei semi che vanno innaffiati e che germogliano con la luce, perché premono, come preme l’umanità di oggi.
E il pubblico che ne fa parte, non può più restare semplicemente seduto a teatro, ma deve rimanere sollevato, mosso, deve ritornare a “pensare spesso”, cioè a pensare a strati. L’avvertimento dello spettacolo, che si amplifica sul finale, quando Bergonzoni, ora dietro un telone, tiene brucianti appelli con toni da Savonarola, è infatti quello di non trasalire, di non trasecolare, come stiamo facendo davanti alla crudeltà, davanti ai vari casi “Cucchi”, “Regeni”, davanti alle centinaia di migranti morti nel Mediterraneo e seppelliti nella “bara-onda”, davanti all’economia che tracima le forze più deboli, ma di trascendere; scavare così a fondo, da passare ad un’altra dimensione, che non è quella dell’odierno “delirio di impotenza”, legati al cappio del prossimo salva il file con il nome. Urge un recupero della morale, della bellezza. È inarrestabile Bergonzoni: “Il teatro lo uso per andare nel vero Senato. Il mio Parlamento reale ha sede nei musei, negli ospedali, nelle scuole, nelle carceri”. Propone un vaccino per “l’egopatia”, ci ricorda che è arrivato il tempo di fare ciascuno il nostro, senza più aspettare la politica o il leader promesso con le sue promesse, perché qui e ora, non ci sono più le anime belle che ci salvano. Possiamo salvarci solo facendo delle nostre esistenze e dei nostri corpi opere d’arte. Diventare gente stellare, per vivere di visioni e non di televisioni. Essere capolavori.
Diana Morea