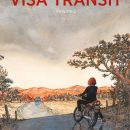“Il crogiuolo” di Filippo Dini riapre in grande la stagione del Teatro Carignano

Ogni volta che assisto a uno spettacolo con la regia di Filippo Dini, regista residente del Teatro Stabile di Torino e vincitore di prestigiosi premi in qualità di attore, so per certo che non rimarrò delusa. E anche questa volta, con la sua lettura de “Il crogiuolo” di Arthur Miller, Prima nazionale al Teatro Carignano di Torino dal 3 al 23 ottobre, sono uscita dal teatro emotivamente coinvolta dallo spettacolo e mentalmente stimolata dalla trama e dalle scelte narrative e registiche. Dini incontra Miller proprio attraverso uno dei testi più lucidi e impietosi della drammaturgia americana, scritto nel 1953 e ambientato nel 1692 a Salem, nella Contea di Essex nel Massachussets, dove Miller si recò in seguito alla denuncia da parte di un amico con l’accusa di essere “comunista”. Quella che Miller, e per osmosi qui anche Dini, racconta è la storia che ha portato all’impiccagione di diciassette persone (fintamente?) colpevoli di praticare la stregoneria. Il testo assume maggiore pregnanza in termini di significato, in quanto scritto in pieno Maccartismo (o anche “caccia alle streghe rosse”): una vera e propria psicosi anticomunista, una follia collettiva che per tutti gli anni Cinquanta generò terrore, condanne e morti. L’esempio di quanto avvenuto a Salem diventa quindi per il drammaturgo il pretesto narrativo per rappresentare la comica demenza della sua contemporaneità e i suoi tragici esiti.
L’inizio “tribale” dello spettacolo in medias res invade la platea di chiaroscuri e fumo, con le attrici che si intrufolano tra il pubblico prima di arrivare al palco. Nel corso dello spettacolo la platea sarà utilizzata più volte come spazio scenico. Interessante è la scelta registica di portare sul palco, dopo questo prologo, tutti gli attori e di presentare uno ad uno i personaggi che tesseranno la trama della storia, per mano di un uomo ormai anziano che si presenta come il vicegovernatore Danforth, all’epoca giudice dei fatti. Sarà proprio questo personaggio ad aprire e chiudere in una struttura circolare la narrazione: un plauso di merito va indubbiamente all’attore che ha vestito i suoi panni, Nicola Pannelli, e che con sapiente consapevolezza ha creato una netta e ben distinguibile lontananza tra le due età anagrafiche del medesimo personaggio.
Lo sguardo di Dini (con Carlo Orlando all’aiuto regia) passa anche attraverso elementi estetici, visivi, o meglio cromatici, che richiamano alla memoria e simboleggiano determinati concetti e stati d’animo. E di questo ho preso consapevolezza quando, seduta in platea e immersa in potenti chiaroscuri, mi sono imbattuta in scenografie e costumi grigi, illuminati sporadicamente da intensi fasci di luce, a cura di Pasquale Mari. Sul palco mancavano i colori, come mancano nella vita e nella tragedia dei protagonisti della vicenda. Sporadiche eccezioni hanno dunque riscosso un effetto di maggiore pregnanza narrativa. Non si può non notare l’imponente bandiera americana che campeggia e domina la scena in tutto il secondo atto, che diventa presenza giudicante e talvolta luogo di rifugio. Ma, vista l’importanza scenica della bandiera, proviamo a considerare i significati simbolici che ai suoi colori sono tradizionalmente attribuiti: il bianco è simbolo di purezza e innocenza, il rosso di durezza e valore, il blu della vigilanza, perseveranza e giustizia. Bene, non a caso le ragazze durante il rituale “demoniaco” sono vestite di bianco per dare l’illusione della loro innocenza e portare il pubblico “dalla propria parte”, e non a caso il vicegovernatore è l’unico con un completo blu (costumi di Alessio Rosati con l’assistenza di Veronica Pattuelli). Inoltre indossa un abito colorato anche il personaggio di Elizabeth Proctor, interpretato dalla splendida Manuela Mandracchia che calza il proprio ruolo in maniera spettacolare, capace di rappresentare una donna colpevole di nulla, se non di essere vittima di una terribile vendetta. La naturalezza dell’attrice si intesse abilmente con l’enorme bravura di Filippo Dini, nei panni di John Proctor, in grado come sempre di far dimenticare al pubblico di essere in teatro e di trascinarlo nella trama. E gli spettatori diventeranno essi stessi protagonisti della storia e giudici, con uno “sfondamento della quarta parete” di pirandelliana memoria ad opera del vicegovernatore, che scende in platea nel momento dell’interrogatorio alla signora Proctor: di fronte alla società giudicante lei non potrà che mentire, per difendere “il buon nome” del marito. È la stessa menzogna negata sul finale, quando John Proctor si rifiuta di mentire nonostante le preghiere del Reverendo John Hale, interpretato da Fulvio Pepe: il ministro di dio costringe i fedeli a mentire, in un rovesciamento della matrice romana del cristianesimo e della superiorità della volontà divina sulla vita, culminando con l’espressione “Gli uomini sono tutti porci agli occhi di Dio”.
Una nota di merito va fatta alle ragazze più giovani del cast per il loro sapiente uso del corpo in scene prevalentemente fisiche: Virginia Campolucci, Gloria Carovana (nei panni anche della signora Putnam), Didì Garbaccio Bogin, Valentina Spalletta Tavella e Caterina Tieghi. Un cast funzionale e affiatato, in grado di reggere il ritmo di un’opera impegnativa come “Il crogiuolo”. Sul palco, infatti, insieme ai nomi già citati: Pierluigi Corallo (Thomas Putnam), Gennaro Di Biase (Giles Corey), Andrea Di Casa (Parroco Parris), Fatou Malsert (Tituba), Paolo Giangrasso e Aleph Viola. L’intrecciarsi di corpi e destini ha permesso la creazione di quadri scenici interessanti e impattanti.
Significativa è stata la scelta di accostare a un evento di secoli fa musica dal vivo suonata da Aleph Viola alla chitarra elettrica, talvolta con la splendida voce di Fatou Malsert. La musica ha quasi una funzione extradiegetica, sembra un elemento di aggiunta alla narrazione, quando invece a produrla sono gli stessi attori. Risulta essere centrale soprattutto in momenti di grande tensione emotiva in particolar modo nella scena iniziale caratterizzata da balli sfrenati (collaborazione coreografica Caterina Basso).
Tengo a fare un ultimo (ma indubbiamente non per importanza) appello al raffinatissimo scenografo Nicolas Bovey che, con l’aiuto di Francesca Sgaribondi, ha saputo rendere tridimensionale e poliedrico lo spazio scenico, attraverso l’utilizzo di due pannelli di struttura diversa che, ruotando, davano luogo a spazi di vita estremamente differenti, ma ugualmente tragici. Interessante è stata anche l’utilizzo dell’iposcenio come uscita di scena, che ha permesso l’ampliamento dello spazio non solo orizzontalmente ma anche e soprattutto verticalmente.
Giulia Basso