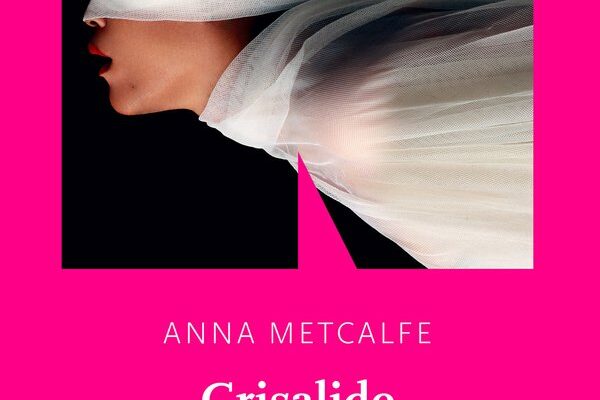Il costo della vita, il costo del nostro io

Deborah Levy (1959) è tra le maggiori scrittrici inglesi. Nata in Sudafrica, è autrice di romanzi. “Il costo della vita” (NN Editore, pp. 168, euro 15) è il secondo capitolo della sua “Autobiografia in movimento”, considerata un caso letterario internazionale in tre volumi.
“Tutto era calmo. Il sole splendeva in cielo, io esploravo i fondali. E poi, quando ero riemersa vent’anni dopo, avevo scoperto che era scoppiata una tempesta (…). All’inizio non ero sicura di riuscire a tornare alla barca, poi avevo capito che non volevo tornarci proprio. In teoria il caos è la nostra peggiore paura, ma sono giunta a credere che potrebbe anche essere la cosa che desideriamo di più. Se non crediamo nel futuro che stiamo progettando, nella casa che abbiamo comprato con un mutuo, nella persona che dorme al nostro fianco, è possibile che una tempesta ci scaraventi più vicino al modo in cui vogliamo stare al mondo. La vita va in mille pezzi, e noi cerchiamo di tenerli insieme. Ma poi ci rendiamo conto che non vogliamo tenerli insieme.”
A cinquant’anni, dopo venti insieme al marito, il divorzio. La casa di famiglia messa insieme pezzo dopo pezzo da lasciare. Il trasloco da affrontare per un edificio art déco che cade a pezzi in cima a una collina nel nord di Londra. Due figlie da crescere, bollette da pagare, il lavoro da scrittrice da gestire.
“Cos’altro potevo fare? Diventare una persona che qualcun altro aveva immaginato per noi non era libertà, era ipotecare la nostra vita per paure altrui. Se non possiamo almeno immaginare di essere liberi, viviamo la vita sbagliata.”
Come diceva Orson Welles, se vogliamo un lieto fine bisogna capire dove concludere la storia.
Deborah Levy, con fatica, dolore e molta energia, lo capisce.
Ed è lì, in quel momento di rottura, che scopre il costo della vita, che non è un riferimento economico, nonostante i conti da pagare, ma il costo che paghiamo per far emergere il nostro io.
E ci troviamo così a leggere la storia dell’emancipazione di una donna già emancipata, ma che esplora tutto il suo potenziale oltre gli schemi prefissi da società e cultura.
Levy diventa l’uomo e la donna allo stesso tempo, è quella che scavalca i ruoli più o meno tacitamente assegnati che vogliono la femmina come “architetto del benessere familiare”, come “moglie di”, senza un nome proprio.
Ci racconta la fatica di definirsi, di lasciarsi emergere, ma anche la soddisfazione nel non voler restaurare il passato e farlo entrare a forza nella nuova vita, bensì di costruire una struttura completamente nuova. È duro, è formativo, ti riempie di energie perché non hai altra scelta, non vuoi avere altra scelta se non quella di andare avanti, di assaporare quella sensazione che è al tempo stesso dissoluzione e ricomposizione.
In questo processo di auto-ridefinizione, emergono il rapporto con la madre e quello con la scrittura, la parola. E si tratta di tre elementi, auto-ridefinizione, madre e scrittura, strettamente legati l’uno con l’altro, che si spiegano, supportano e perdonano a vicenda.
La piena comprensione della figura materna che già, come la figlia, era sfuggita a schemi prefissati, arriva quando ormai è morta, ma non per questo ha meno peso nel ridisegno della Levy come madre/donna.
Ridisegno nel quale la scrittura ha un ruolo chiave. Chiusa a scrivere nel capanno che la vicina di casa le ha prestato, Levy si trova faccia a faccia con il suo io e con la parola, quella che si lotta per trovare, confermandone la vitalità; quella che fin da piccoli ci dicono di esprimere ma che poi quando cresciamo spesso censurano.
E dunque, un canto di vita, di libertà, di slancio, nonostante gli inciampi. Un inno al caos che a volte è proprio ciò che ci serve.
“Le parole che state leggendo sono fatte con il costo della vita e inchiostro digitale”.
Laura Franchi