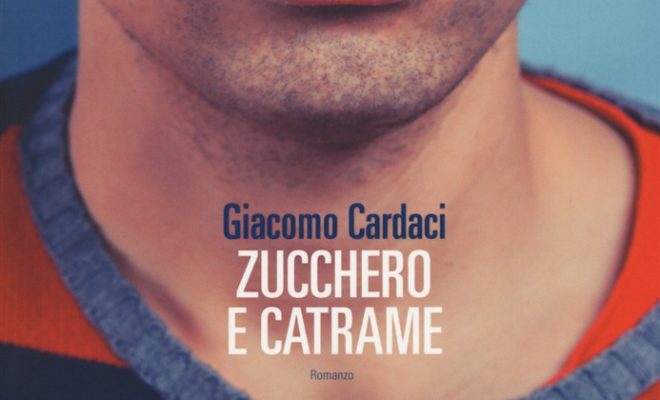“Febbre” – Il primo romanzo di Jonathan Bazzi

Il 9 maggio è stato pubblicato “Febbre“, il primo romanzo di Jonathan Bazzi edito da Fandango. Cosa accade ai bambini delle periferie dimenticate? Come si vive oggi con l’HIV? Perché alcuni di noi nascono in luoghi che non ci sanno accogliere? Creeremo mai una società meno incline all’iniquità e alla violenza? Queste sono solo alcune delle frequenze attraverso le quali vibra e si propaga l’efferata prosa di “Febbre”.
Jonathan Bazzi è nato a Rozzano, estrema periferia sud di Milano, che aveva poco da offrire a un ragazzo curioso e lontano dai preconcetti imperanti in alcune delle nostre comunità. Un’infanzia complessa, una famiglia ingombrante e spesso impreparata, un’istruzione discontinua ma in fin dei conti solida nei contenuti, soprattutto quelli umanistici. Jonathan scappa da Rozzano e va a Milano, l’affascinante metropoli che lo aiuterà a riscattarsi. Tre anni e mezzo fa, poi, scopre di essere sieropositivo. Due storie – l’infanzia nell’hinterland e il periodo milanese di indagine medica – che corrono parallelamente e che si alternano nella successione dei capitoli. Un libro ponderato ma accattivante, denso ma scorrevole: Jonathan procede un anelito di libertà alla volta, racconta di sé ma poi racconta di tutti, colpisce il cuore e la mente con l’arguzia di chi (molto semplicemente) svela il mondo per quello che è, con tutte le incoerenze che ancora non abbiamo risolto. Di recente ho avuto la possibilità di chiacchierare con lui, ed ecco cosa ci siamo detti.
D.M.A. – Dunque Jonathan, “Febbre” racconta essenzialmente di te, di alcuni segmenti molto intimi della tua vita. Come ti sei sentito a esporti così tanto? In un mondo in cui tante persone esibiscono delle personalità costruite, tu cosa provi all’idea di condividere la tua verità?
J.B. – Per indole, il mio bisogno di privacy è molto limitato. Io non ho problemi a raccontare anche degli aneddoti che potrebbero gettare su di me delle luci sgradevoli; non mi piace l’autocensura basata sull’omertà o sulla cultura del pudore. In me è molto più forte un altro istinto: mi interessa imparare dalle cose che mi succedono e che mi sono successe, renderle degli strumenti di riflessione e di intrattenimento narrativo.
D.M.A. – Il tuo libro obbliga chi lo legge a riflettere su tanta polvere che nascondiamo sotto il tappeto: l’ineducazione sessuale, l’abbandono delle periferie, l’ignoranza, l’ingiustizia, i pregiudizi. Non hai mai avuto paura che tutta questa vita vera potesse non interessare o addirittura infastidire un certo tipo di pubblico?
J.B. – Io sono convinto che questi temi accomunino molti lettori, perché obiettivamente chiamano in causa una grande parte della società. Sicuramente, poi, “Febbre” potrebbe infastidire qualcuno. Penso, per esempio, a coloro che non sono particolarmente sensibili al tema delle disparità di genere o alla messa in discussione delle forme contemporanee di patriarcato. Il mio è un romanzo schierato, prende una posizione, descrive il mondo da una prospettiva precisa. Però questo non significa che la storia che racconto sia solo mia o che sia comunque poco rappresentativa della società. E infatti si tratta di un romanzo, non di un’autobiografia: io ho voluto raccontare, non trasmettere dei dati. L’intento era di riferire dei fenomeni – penso per esempio all’HIV o alla balbuzie – con un registro nuovo, che stridesse con gli sguardi depositati.
D.M.A. – Parliamo di stile. A livello formale sei istintivo oppure costruisci la tua narrazione?
J.B. – Io prediligo le prime stesure veloci, adrenaliniche. E, se non mi sento connesso a questa dimensione fluviale, interrompo e riprendo in un altro momento. Però poi rileggo moltissime volte, quasi ossessivamente, e allora aggiusto, taglio, aggiungo, giro le frasi, senza però allontanarmi mai troppo dal flusso iniziale. Credo molto in una prima fase slanciata, dinamica, ritmata, ma anche in una seconda fase dedicata alla revisione, alla cesellatura del testo, lenta ma non diradata.
D.M.A. – Se dovessi creare un podio di autori viventi a te particolarmente cari, chi sceglieresti?
J.B. – In questo momento mi sento molto vicino a Joyce Carol Oates, Teresa Ciabatti e Rosa Matteucci.
D.M.A. – In altre occasioni ti è capitato di parlare anche della tua predilezione per autrici come Elsa Morante, Alda Merini, Oriana Fallaci e altre. Secondo te c’è qualcosa di loro nel tuo libro?
J.B. – Penso che ci siano delle affinità inevitabili tra ciò che ci piace come lettori e il modo in cui scriviamo. Ciò che accomuna tutte queste autrici – e che io cerco di ricreare nella mia scrittura – è la vividezza, l’incisività. A me piace quella scrittura concreta che riesce a essere molto curata ma anche estremamente abile nel toccare il lettore, nell’accendere delle reazioni emotive. E secondo me questo tipo di stile, che io ritrovo nelle autrici che mi interessano, riguarda in un certo qual modo anche me. Io non mi sento molto conforme a tanta prosa italiana, perché spesso gli autori annacquano molto la carica vitale dei loro contenuti. Io ho scritto in prosa, ma il mio stile riparte dalla poesia, soprattutto quella femminile contemporanea: idealmente manterrei sulla carta solo le parole belle, forti; mi muoverei esclusivamente per passi puntiformi, come una specie di esteta radicale che elimina tutte le frasi inutili. Come fanno le autrici che io prediligo.
D.M.A. – C’è un punto nel libro in cui racconti di un periodo in cui i compagni di scuola erano molto invidiosi dei tuoi rendimenti in termini di voti. E tu scrivi “Non provate a imitarmi. Non si copia un destino”. Quest’ultima frase mi ha riportato al prologo di Leucippe e Clitofonte, dove Achille Tazio racconta la sua preghiera iniziale alla musa affinché lei non gli dia solo l’ispirazione, ma anche un destino. Perché se gli uomini sono predestinati a qualcosa, allora possono impiegare il loro tempo tentando di raggiungere la loro completezza. Quindi tu e Tazio dite una cosa molto simile: chi ha un destino forse è un po’ più fortunato rispetto a chi non ne ha uno. Tu come ti poni rispetto a questa problematica? Il destino esiste o no? Perché, per esempio, alcuni nascono in determinati luoghi e altri, come te, vengono educati in ambienti scomodi, sgradevoli? Si tratta solo di un caso?
J.B. – Di base, io credo al destino. Non in un senso religioso, però ci credo. Anche se, strada facendo, aggiorno i miei pensieri in proposito. Sicuramente, per me, l’idea di destino (anche in relazione alla citazione che proponevi) si lega più che altro alla questione della forma. Sperare di essere predestinati a qualcosa significa anelare a una forma organizzata, predefinita. Se siamo predestinati a qualcosa, allora c’è un senso logico che attraversa le varie propaggini del progresso spazio-temporale. Volendo essere sincero fino in fondo, penso che questa consapevolezza mi abbia salvato: come racconto nel libro, io ero molto affaticato da varie questioni che mi hanno reso la vita difficile. E sono stato aiutato dall’idea che esista un luogo naturale per ognuno, per dirlo in termini aristotelici. Il mio luogo naturale non è quello in cui sono stato cresciuto, e credo che la sensazione sottile ma radicata e costante di essere inserito in una tensione di questo tipo mi abbia sostenuto in passato. E penso mi sostenga ancora oggi. Quindi, se io sono riuscito a emanciparmi dal mio milieu è stato anche grazie alla fede che avevo, e che ancora ho, per un certo modello di predestinazione.
Davide Maria Azzarello