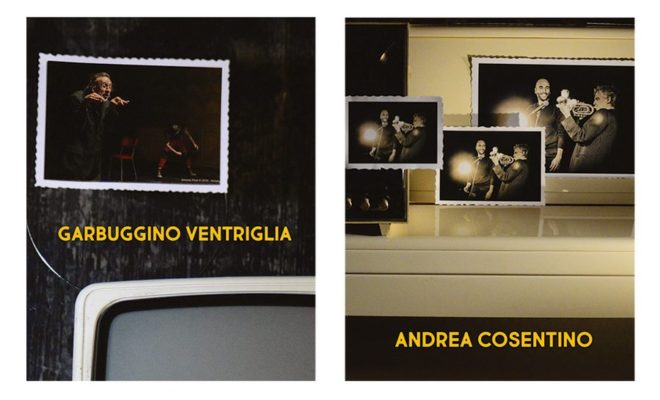“Enigma requiem per Pinocchio”: la potenza salvifica del rito teatrale

Quando ci si imbatte nel Teatro Valdoca, storica compagnia di ricerca della Romagna Felix, si ha il privilegio di assistere ad una “nuova esplorazione del corpo”, per usare un’espressione cara a Deleuze. Donando il tempo che l’attore vive in scena, dona il suo racconto, ed è questo un dono che resta.
Lo testimonia la felice permanenza della loro recente opera al Teatro India, dal 19 al 27 marzo, dal titolo “Enigma requiem per Pinocchio”. Il personaggio di Collodi, passando per Manganelli, e dimenticando entrambi, diviene un pre-testo per indagare sul mondo vegetale, sulla sua memoria residua di pezzo d’albero, sul suo sguardo sbigottito verso l’umano di cui entra a far parte. Una dedica raffinata a chi è ancora capace di stupore e spavento, e che si serve del rito, in questo caso sonoro e visivo, da sempre in grado di attribuire significati all’esperienza del vivere. Nella sapiente collaborazione tra Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi, il rito diventa una manovra geometrica, in cui tutti gli elementi sono messi perfettamente a punto, perché accada quello che Amelia Rosselli chiamava “incanto fonico”. In passato, il rito di iniziazione sanciva il passaggio dalla vita dell’infante a quella dell’adulto. Per farlo richiedeva una drammatizzazione, si doveva esperire ciò che il rito figurava. L’iniziato veniva separato dalla comunità e condotto nella zona liminale, il margine tra noto e ignoto. L’infante viveva, così, un’esperienza di totale indefinitezza. Si doveva morire alla vita bambina per rinascere a quella adulta. Ed è quello che rievoca Enigma dei Valdoca, ossia il senso arcaico della lotta tra la vita che se ne va e quella che resiste.
Sulla scena, plasmata da Mariacristina Navacchia, fiori di ciliegio, slitte di legno, candele luminose, una immensa luna piena, una scala, una croce, sono i simboli di questa veglia funebre, sostenuta dal canto cerimoniale di Silvia Curreli e Elena Griggio. Il corpo di legno di Pinocchio giace su una lettiga, coperto da un lenzuolo bianco, in quella che un tempo era la bottega di Geppetto. Siamo fin da subito rapiti dal rumore degli zoccoli di Silvia Calderoni che avanza dal fondale con passo dinoccolato, forza di ribelle e la sfrontatezza di chi scalcia nella bara a dispetto della favola. Tutto, nella sua “contentezza di fuga solitaria”, negli atteggiamenti angolosi, nel ghigno da automa, nelle danze smodate da fantoccio animato, è sublime incoscienza. Nel suo mondo infantile, fatto di sensazioni sfocate, il gioco solleva e non ha bisogno di abbecedario. Gli altri personaggi appaiono come fantasmagoriche visioni, a partire dalla fatina Chiara Bersani, l’unica rimasta davvero parlante, “viene da lontano, dove il respiro non conta”. Il suo è un andare piano, come una piccola lumaca, che diventa abitato, fecondo. Un corpo straordinario in cui il meschino si fa grazia, la ferita luce intensissima, e che condensa risate di tenerezza, dolore straziante, coraggio e fragilità. In questa disponibilità nuova di ascolto del diverso si azzera qualsiasi tipo di pregiudizio, e superare il limite è sinonimo di schiettezza eroica. “Cosa può insegnarci,- questa fatina- se non l’amore? Diventare uno con tutto quello che c’è”. E ancora Mangiafuoco, Matteo Rampolli, con il suo alfabeto corporeo imponente e le membra possenti, alta è la sua statura, tanto da far vibrare il soffitto. Identità diverse, armonizzate e sintonizzate in una sorta di unica mente sensibile e organica. A guardia della soglia tra Inferno e Paradiso vi è l’io del poeta, fine conoscitore degli elementi della natura. Porta su di sé tratti inconfondibili, il segno della morte, ma anche un marchio di salvezza. Il verso di Mariangela Gualtieri passa per la materia del corpo di tutti i personaggi, facendoli risuonare. Una voce deformata, amplificata, come fuoriuscita da una veridicità che non si discute. La poesia che apre al sacro, a tutto quello che è invisibile, indicibile, che sta prima della ragione e che si concretizza nelle vibrazioni sonore. Aver cura delle parole, giocarci come elementi sonanti vuol dire accendere questi pezzi di legno e far divampare la meraviglia del fuoco.
Il paesaggio sonoro creato da Attila Faravelli, Ilaria Lemmo e Enrico Malatesta poggia su un intreccio di suoni metallici, percussioni, frammenti marziali e silenzi che sollecitano una commozione del piano d’ascolto. Le luci abbaglianti dei fari inondano sul finale lo spettatore in un effetto estatico abbacinante, con un fuoco pirotecnico di suoni e bagliori che rappresenta un momento di epifanica bellezza. Una festa del corpo che tiene al centro l’ebbrezza e una potenza salvifica. E il rito del teatro, come la fiaba, ci salva ogni volta, perché ciò che si è visto anticipa la vita e, in qualche modo, la rende tollerabile.
Diana Morea