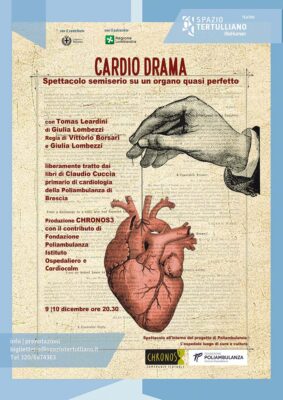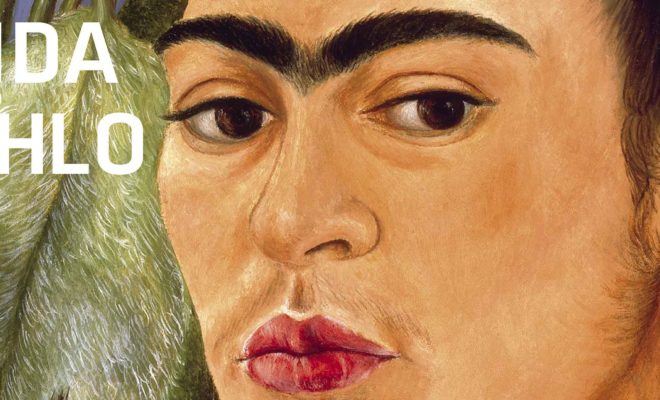Disgraced al Teatro India. Caduto in disgrazia, come la realtà

DISGRACED al Teatro India, Roma
Da dove nasce la guerra, o almeno quella che sempre più voci istruiscono a pensare come tale? In Disgraced, in scena ai Filodrammatici, può nascere da un appartamento di design, a Manhattan. Uno di quei luoghi minimalisti che vogliono convincere chi ci entra di essere proiettati nel futuro, imporre il proprio lusso ostentando minimalismo come solo New York sa. Un candido, scintillante spazio dentro al quale si muovono un avvocato di successo e sua moglie, aspirante pittrice esotista. Però il sogno americano ha un prezzo, che ha a che fare col nascondimento, soprattutto della propria identità.
Così Amir, l’avvocato, si dichiara indiano ma è nato in Pakistan, e suo nipote (Marouane Zotti) Hussein Malik si fa chiamare Abe Jensen. Fuori dalla bolla dentro alla quale la bella e WASP Emily cerca l’affermazione magnificando e replicando l’arte islamica del Quattrocento, e Amir non perde occasione di disprezzare l’Islam, c’è però un’America fosca, quella del presente. Quella dove è sufficiente essere musulmani per venire prima o poi braccati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Basta che un familiare venga a chiedere aiuto per liberare: “un uomo che non ha nulla se non la sua dignità e la sua fede, e cerca di essere utile nel solo modo che conosce”. E non serve tutta la prudenza che un avvocato può accampare: basta che ci si voglia leggere un passo falso. E in un istante la rovina incombe, come suoni dissonanti che disturbano il filo dei pensieri, ombre di passi proiettate sui muri anche delle case più lussuose. Magari portate da un vecchio amico che può decidere la buona sorte o il fallimento, come il gallerista ebreo Isac, (Francesco Villano) alle prese con la propria guerra personale con sua moglie afroamericana, Jody, interpretata da Saba Anglana. E così, nel ritmo cadenzato di una cena tra amici, l’oggi presenta il suo doloroso conto, che traccia gerarchie di accettabilità tra minoranze, che svela con sincerità tagliente l’ipocrisia e il razzismo nelle parole eleganti della società politicamente corretta, dove il nemico ha un volto preciso, quello mediorientale, e dove, chiosa amaro Amir, “il prossimo terrorista avrà un volto che mi somiglia”. O “sarà un bianco che punterà un arma che non dovrebbe possedere”, gli viene risposto, conto qualcuno con quel volto. Presa coscienza di questo, non possono che cadere tutti i falsi buoni sentimenti, davanti a una realtà dove tutto succede e nulla si dice, e nessuno si fida di chi è già diventato nemico a prescindere.
Jacopo Gassman offre una regia curata e un uso creativo di musiche e luci a un testo potente, che affonda con la precisione e l’inevitabilità di un bisturi nella carne viva del presente e mette sul tavolo tutte le domande e le frasi cui spesso la scena preferisce nascondere sotto. Merito soprattutto di un cast di ottimi attori, su cui spicca Hussein Taheri in stato di grazia nei panni di Amir, che nella sua parabola ci impone una lezione spietata. “Non è un mondo neutrale quello in cui ti trovi, non in questo momento”. È un mondo che ha già scelto i buoni e i cattivi, e allora non ti resta che assomigliare il più possibile ai primi, se vuoi sopravvivere e se puoi. “Tu vuoi da questa gente qualcosa che non otterrai. Hanno fatto in modo che volessimo diventare come loro, e poi fanno finta di non capire la rabbia che proviamo”. E allora, in un contesto in cui appartenere è sempre una prigione, la guerra arriva da fuori, da sopra di noi. E non può essere disertata da chi ha a disposizione solo sguardi, gravidi di sentimenti che non hanno parole per essere espressi.
Chiara Palumbo