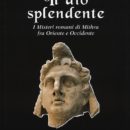COME UNA FIABA INVERSA. “LA LUCINA” DI FABIO BADOLATO E JONNY COSTANTINO

Un grande fuoco scintilla e crepita in mezzo a una buia notte, una mano stretta in un pugno si staglia dentro la fiamma, un uomo vestito di nero si stacca dalle pareti d’ombra e inizia a camminare in cerchio intorno al rogo; esita, in obbedienza a un rituale del cui senso sembra ormai dubitare. Non manca però l’oggetto destinato a essere bruciato e sui carboni ardenti getta la propria carta d’identità, forse per propiziare una rinascita o come segno di un definitivo congedo. Il nome e l’immagine del volto sono rapidamente divorati, ma prima di cedere alla cenere resistono ancora un istante per apparire come in un’incisione in negativo: il fuoco – e la messa a fuoco dell’obiettivo – brucia la materia e rivela un doppio invisibile che sta dentro o contiene il visibile. È questa la prima sequenza del film “La lucina” di Fabio Badolato e Jonny Costantino, tratto dall’omonimo libro di Antonio Moresco, che è inoltre non solo co-autore della sceneggiatura insieme a Jonny Costantino, ma anche interprete principale. È lui l’uomo che cammina intorno al fuoco, l’uomo che brucia il nome e con esso quella “prima morte ma assolutamente occulta”. Non è certo un attore professionista, come nessuno in questo film. Non ci sono attori e nemmeno personaggi, piuttosto, à la Bresson, “modelli”, anima e corpo inimitabili, che identificano una fisiognomica esistenziale.
Lo scrittore Antonio Moresco, qui, è il suo corpo: alto, magro, dinoccolato, è la nero-inchiostro filiforme figura dei disegni dei Diari di Kafka o l’Homme qui marche di Giacometti; se il suo aspetto evoca il “rabbino infelice” di Rembrandt, il suo sguardo è animalescamente quello di un gufo, più precisamente, per via del colore di barba e capelli, di un gufo bianco delle nevi, che come la civetta, per i suoi occhi spalancati nella tenebra, simboleggia riflessione, morte e conoscenza dell’aldilà, tutto quel mondo che non vediamo. Un’altra scrittura dunque insinua nel suo corpo un movimento che lo altera: quello della camera da presa. Consumato il rito, l’indomani mattina – anche se qui il tempo è solo una distensione dello spazio – l’uomo è ripreso e seguito nel compimento di gesti ordinari, quali alzarsi, lavarsi, vestirsi; spogliate di ogni naturale istintività, le movenze sono spezzate lungo le linee di una gravosa meccanicità. Come spezzato e soffocato è il suo respiro, sempre meno capace di trattenere le cose da un’inesorabile deriva. In ogni movimento, tuttavia, appare l’opposizione tra la rivolta e la resa. L’uomo abita, o piuttosto occupa una piccola povera casa isolata che la sua presenza riesce a rendere ancor più deserta e abbandonata. È il luogo di un passaggio, ma di cui si ignora la durata. Il tempo si svuota di ogni attesa. Nel frattempo occorre stendere un lenzuolo al sole e al vento, pulire il caminetto e spaccare la legna per ancora un altro fuoco! A sera, sparita l’ultima linea dell’orizzonte, a poca distanza dalla sua piccola casa, l’uomo, seduto su una seggiola di ferro, sbilenca sul terreno, scruta la tenebra in cui il mondo sembra sprofondare. Qualcosa interviene a lacerare la nera tela, come uno squarcio di “desiderio” (assenza di stelle). Quando l’oscurità della notte ricopre ormai ogni cosa, dall’altra parte della gola, su un’altura di fronte, compare infatti una lucina. Ogni notte, alla stessa ora, una lucina si accende all’improvviso. La lucina segna l’inizio di un’erranza. L’uomo s’inerpica per le stradine del borgo vicino, che di notte è deserto e ancor più remoto. Remoto è il paesaggio che lo circonda, solcato da argillosi e impermeabili calanchi, che sembrano stagliare informi e gigantesche statue di sale, accecate per essersi voltate a guardare il mondo nell’istante della sua dannazione. I pochi volti del borgo, non meno delle case di pietra tenacemente strette le une alle altre, appaiono scavati dai medesimi solchi, resistenti e tuttavia sul punto di sparire in un turbinio di polvere. Nessuno abita al di là della gola, così tutti sanno in paese. L’uomo inizia allora il cammino verso il luogo da cui proviene la lucina. Un cammino da farsi a piedi e non segnato da sentieri. A rimarcare lo scarto o il salto richiesto è la prima tappa: spezzare il corso delle acque gettandovi pietre a sostegno del passo. L’uomo attraversa così il torrente della gola, risale a fatica la collina, inoltrandosi tra sterpi e arbusti nodosi, nella radura solo carcasse di animali o rottami contorti, uniti nel supplizio di una sola materia; un tronco mostra una ferita sanguinante, è forse l’albero dell’orribile selva dei suicidi di Dante, dove le anime sono incarcerate in piante. Infine una costruzione che non scorgiamo per intero, davanti alla quale l’uomo sembra colto da una paurosa e affannosa esitazione. Da una porta semiaperta si affaccia all’interno di una povera casa, dove un bambino sta lavando le lenzuola, ma per quanto in primo piano non è a fuoco, lo è invece l’uomo sullo sfondo e alle sue spalle, che spalanca i suoi occhi da civetta per porre semplici domande, ma lo scambio più che illuminare produce silenzio. In un pellegrinaggio quotidiano, l’uomo tornerà con il suo domandare dal bambino che abita da solo in mezzo al bosco: è il movimento di una fiaba inversa. Il volto del piccolo, impersonato da Giovanni Battista Ricciardi, è infine portato a fuoco, grazie a una soluzione visiva che facendolo saltare fuori da una porticina dentro una porta esaspera un passaggio di soglia che raddoppia il piano della realtà. Diafano ed esangue, il suo incarnato è bianco come il lenzuolo che l’uomo tirerà sul proprio viso per sottrarsi o consegnarsi a uno schianto della terra. Simile all’Arlecchino con specchio di Picasso il bambino conserva in absentia la vivacità policroma propria della sua età. In lui ogni mobilità di tratti sembra essere assente. La sua stessa presenza appare traccia di un assente o di un invisibile presente. Non ha nome, non lo sa, non lo ricorda, ma i compagni della scuola serale che frequenta lo chiamano, sempre ignorando il perché, Stucco: una parola in sonoro contrappunto alla visione delle pareti scrostate e ammuffite, così simili a un’oscura vegetazione, di un’altra casina abbandonata, che il bambino misteriosamente rassetta e prepara. Semplici e oscure, le risposte del bambino sgomentano l’uomo fino a pietrificare il suo volto – una delle tante pittoriche inquadrature – in argillosi tratti tali da renderlo simile a un Cristo morto del Mantegna. Il suo interrogare tuttavia non si arresta, anzi si espande come lo stesso universo a cui si rivolge, fatto di spazi profondi, di materia ed energia oscura, di un invisibile che “grava” sul visibile, di una luce forse dentro un’altra luce, di cui è piega e buco, un doppio senza il quale nulla sarebbe distinguibile, annientato in una luce senza limiti. Un doppio è il bambino, che l’uomo raggiunge oltrepassando una soglia. Solo allora diventa il suo Doppelgänger in senso letterale, vale a dire un “doppio camminatore”, con il quale si comincia o si riprende un cammino che di ogni luogo dice non è questo, non si può risiedere qui né contentarsi di ciò. Questo è l’incedere del mistico separato per sempre da un necessario divenuto l’impossibile.
“La lucina”, infatti, è un racconto altro di quegli uomini partiti in cerca della visione, più precisamente è una variazione o meglio una fuga dell’enigmatica parabola Davanti alla Legge di Kafka, dove l’uomo di campagna alla fine della sua vita, ormai cieco, avverte un bagliore inestinguibile provenire dalla porta della legge e pone un’ultima domanda al guardiano, perché mai altri non si fossero presentati per chiedere di entrare. La risposta è nota: quella porta era destinata soltanto a lui e ora sarebbe stata chiusa. Così anche nella Lucina la chiarezza è solo testamentaria.
Rossana Lista