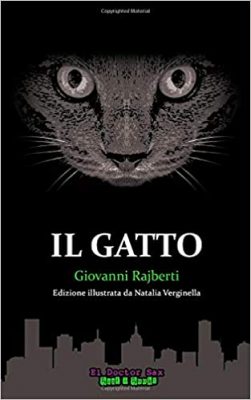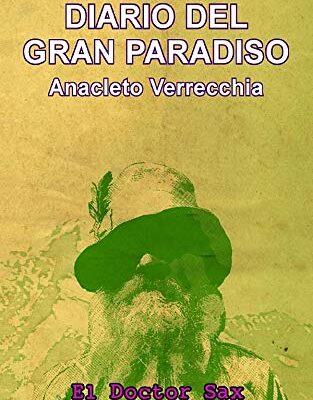“Amore, morte e rock ‘n’ roll”: storie di anime irrequiete che hanno fatto storia – Intervista a Ezio Guaitamacchi

Lo scorso 6 novembre 2020 è uscito “Amore, morte e rock ‘n’ roll” – Le ultime ore di 50 rockstar: retroscena e misteri (Hoepli, Collana Musica, pp. 345, euro 29,90), il nuovo libro di Ezio Guaitamacchi, scrittore, giornalista, autore e conduttore radio/tv, docente e performer. Il libro è arricchito dalle prefazioni di Enrico Ruggeri e Pamela De Barres, una delle groupie più iconiche negli anni Sessanta e Settanta) e dalle illustrazioni di Francesco Barcella. Un libro pieno di storie e di curiosità, che ripercorre gli ultimi momenti di personaggi che hanno lasciato un segno nella storia della musica, una lettura che coinvolge e appassiona, con sfumature a volte misteriose e canzoni che in alcuni casi contenevano versi premonitori. Per addentrarci ancora meglio nel rock presente nelle vite dei personaggi narrati, abbiamo fatto qualche domanda a Ezio Guaitamacchi.
Il 24 novembre ricorre un anniversario importante: la morte di Freddie Mercury, lei ha visto il film di Bryan Singer “Bohemian Rhapsody” che uscì nel 2018? Cosa ne pensa?
Ho visto il film e non mi è piaciuto, l’ho trovato enfatico, pieno di errori. La cosa apprezzabile è che il successo che ha ottenuto quel film ha fatto appassionare, scoprire o riscoprire la figura di Freddie Mercury. Per gli amanti del rock di un certo tipo i Queen non sono mai piaciuti più di tanto, perché in quello stesso periodo c’erano artisti ben più interessanti, dai Led Zeppelin ai Pink Floyd. Sicuramente Freddie Mercury è stato un performer straordinario, un personaggio di rilievo, creativo, e dal mio punto di vista è il pregio maggiore del film. Premetto che non sono un critico musicale, ma il film, come molti di questi biopic, tratta in modo troppo esagerato argomenti delicati come i retroscena personali dei soggetti, facendo dimenticare altre questioni più importanti. Il tutto andrebbe trattato con un po’ più di rispetto, senza eccessi di spettacolarizzazione, perché le vite delle rockstar, e quella di Freddie non fa eccezione, sono talmente straordinarie, talmente surreali per certi versi, che, secondo me, non hanno bisogno di essere enfatizzate più di tanto o spostate verso il versante del gossip. Credo che quello che manca in quel film sia l’aspetto poetico dell’artista e la poesia del suo finale di vita, che è quella che io ho cercato di mettere a fuoco nel mio racconto. Al di là di veri o presunti retroscena su quella vicenda ci sono scelte precise che l’artista ha fatto e tutto il suo mondo affettivo con le persone che l’hanno circondato, di cui lui si fidava e che sono state vicino a lui fino all’ultimo respiro.
Il libro è stato suddiviso in sei categorie, si inizia da “Tears in Heaven”, con le morti naturali e termina con “Blood Brothers” e il grande finale sulle morti di Sid Vicious e Nancy Sprungen; come ha organizzato la suddivisione e la successione degli artisti e quando ha realizzato i punti in comune?
Da circa trent’anni mi occupo di musica a livello professionale, ma anche di edizioni di collane di libri musicali; questo libro esce per la collana di musica della Hoepli che dirigo dal 2014. Avendo fatto il direttore di riviste musicali, sono consapevole del fatto che bisogna avere un certo metodo e seguire delle impostazioni: è il primo criterio nel momento in cui si scrivono dei saggi e non libri di narrativa, dovevo trovare un sistema per aggregare le varie storie. In genere, quando si scrivono i saggi storici, il criterio utilizzato è l’ordine cronologico, ma in questo caso ho voluto trovare un altro sistema proprio perché raccontavo i finali di vita con un certo tipo di sguardo, che prevedeva – e da qua l’inserimento della parola “amore” nel titolo – anche il fatto che la morte è una cosa che accomuna tutti gli esseri umani, anche quelli che abbiamo considerato e consideriamo delle specie di divinità o dei semidei: la morte li porta al nostro livello, li rende “più simpatici” perché atterrano dalla stratosfera divina alla nuda terra. Quindi, il discorso della tipologia di morte, seppur macabro, mi sembrava quello che si prestasse meglio a mettere insieme personaggi di epoche diverse e di mondi musicali diversi. Io uso il termine “rock” in senso lato, non strettamente legato al genere: sono tutti spiriti rock: il bluesman Robert Johnson, Otis Redding, Aretha Franklin, Whitney Houston, George Michael, tutti erano inquieti, ribelli, antagonisti, un po’ come è stata la musica rock dal momento in cui è nata. Ho cercato di attenuare il macabro usando dei titoli di canzoni che fossero sufficientemente espliciti da rendere l’idea e utilizzando anche dei sommarietti di fianco all’illustrazione che apre ogni sezione del libro. Così facendo, anche l’ultima sezione “Blood Brothers” è ancor più giustificata perché va ancora di più nel dettaglio. Ci sono state liaison ovvie, come Tim e Jeff Buckley, padre e figlio, oppure Sid e Nancy, una murder ballad trasferita nella realtà, ma anche altre meno ovvie: l’appartamento di Harry Nilsson in cui muoiono Mama Cass e Keith Moon, la morte di Boris Johnson degli AC/DC sul sedile di una macchina, che mi ha fatto venire in mente che anche il grande artista della country music Hank Williams fece una fine tragica allo stesso modo. Peraltro, ci sarebbero stati un sacco di altri fil rouge che potevo intrecciare, ma avrei dovuto strutturare il libro in un altro modo che, secondo me, sarebbe risultato meno leggibile. Ci sono un sacco di connessioni anche poco prevedibili, basti pensare che il giorno in cui viene ucciso John Lennon, David Bowie era a New York e stava facendo uno spettacolo teatrale. Io ho preferito strutturarlo in questo modo, ogni racconto è a sé, ho voluto separare i momenti di approfondimento: prima si legge la storia e poi altre curiosità: misteri, retroscena, aneddoti, approfondimenti, che hanno più un sapore giornalistico, che non di racconto vero e proprio. Poi ho voluto mettere le canzoni, sarei felicissimo se un lettore mi dicesse “ho letto la storia di Gram Parsons, non sapevo chi fosse e sono andato ad ascoltare la sua musica”.
Che peso hanno nelle storie le canzoni che sembravano predire quello che poi è effettivamente successo?
Quando si scoprono certe cose le spiegazioni si sprecano. Nella prefazione Enrico Ruggeri sottolinea la fragilità dell’artista, che è data anche da un eccesso di sensibilità, che giustifica l’egoismo come il tratto distintivo di ogni artista e nasconde la generosità nel trasmettere. La musica è quello che alla fine resta, io non ho cercato dei greatest hits, ma canzoni che fossero significative della storia che stavo raccontando, così come le immagini. Le canzoni dovevano essere la colonna sonora giusta: idealmente immagino di leggere il racconto di Bowie e ascoltare “Lazarus”. Nel caso di David Bowie si tratta di una consapevolezza assoluta, “Black star” è un album epitaffio in cui l’artista si confronta con la sua morte, reso ancora più forte quando uscì il video del brano. Per altri artisti invece si tratta di semplice casualità, anche perché a 25/30 anni l’idea della morte, di norma, non sfiora personalmente, è qualcosa di molto lontano, a meno che non si tratti di un personaggio talmente autodistruttivo, talmente nichilista da avere quella visione. Non so cosa avesse in testa Jeff Buckley quando ha scritto quelle liriche che sembravano il racconto della sua morte*. Una volta a Memphis andai a vedere l’affluente del Mississippi in cui Jeff è affogato: a una persona lucida non verrebbe mai in mente di andare a fare il bagno in quel posto perché non invoglia, mentre lui ci è entrato vestito e cantando i Led Zeppelin, quindi non era in sé. Possono anche essere semplici coincidenze, anche se lette a posteriori raccontano delle cose, ad esempio per i Lynyrd Skynyrd: la copertina del loro disco è stata una coincidenza maledetta, non vedo altre spiegazioni.
*“And I couldn’t awake from the nightmare that sucked me in / And pulled me under, pulled me under” (“So real” dall’album “Grace”, 1994).
Mi ha colpito la figura del manager. Quando gli artisti diventano famosi, delle rockstar, il manager pensa molto di più a fare soldi con l’artista che all’artista stesso, mi riferisco ad esempio alla figura di David Geffen e a quello che è emerso da alcune storie presenti del libro, che cosa ne pensa?
Questo vale per tutti gli artisti e anche per i personaggi dello sport o di mondi in cui il protagonista è un personaggio pubblico, ma suggerirei di vederla anche in un altro modo: il manager è spesso il fautore delle fortune dell’artista stesso. I Beatles senza Brian Epstein forse sarebbero arrivati lo stesso, ma erano stati rifiutati da diversi discografici; il manager non è una persona che per contratto deve voler bene all’artista, deve fare il bene dell’artista inteso come carriera professionale. Poi c’è chi esagera o ci sono quelli che per anni hanno trascurato i loro artisti, ma fa parte della vita. Io credo che in questi casi non sia giusto puntare il dito, a meno che non ci siano delle prove. Il “complotto Geffen” l’ho messo come rumor, non è provata come cosa, ad ogni modo David Geffen alla fine degli anni Sessanta fu il fautore della scena della West Coast californiana che produsse la miglior musica di quel periodo, prima con la sua casa discografica Asylum e dopo con la Geffen Records. Quando racconto le storie non dò mai una soluzione, magari trapela una mia interpretazione, ma poi lascio fare al lettore. Io punterei il dito sui genitori degli artisti, i mariti, le mogli… laddove ci sono stati dei casi in cui l’amore – che io uso nel titolo intendendo anche l’opposto, dove non c’è amore, ma solitudine – può diventare complice del delitto. La musica è come il calcio: quando ci sono giovani che hanno un successo stratosferico in breve tempo, è molto probabile che ci sia chi si approfitta di loro, però è più grave avere finti amici. C’è un pezzo clamoroso degli anni venti che cantava Bessie Smith che si chiama “Nobody knows you when you’re down and out”: quando uno è in auge sono tutti amici, appena vai giù non c’è più nessuno. Purtroppo questa è una tragica legge della vita che è ancora più clamorosa quando il successo viene e poi va.
Il discorso sul manager vale anche per il Dr Feelgood**?
Le due cose si assomigliano, ma in questo secondo caso è più grave. Anche queste sono relazioni di tipo economico: il dottor Conrad Murray lavorava per Michael Jackson in esclusiva, non era stato ingaggiato dall’artista direttamente, ma dall’agenzia che promuoveva gli spettacoli “This is it”. Quel tipo di artisti non sono abituati a sentirsi dire di no, anzi preferiscono circondarsi da yes-man, non hanno una vita normale, sono fuori dal mondo anche per quanto riguarda la loro salute. Jackson prendeva il Propofol, un anestetico usato in chirurgia, perché aveva l’ansia e non dormiva, stiamo parlando di un uomo di cinquant’anni, con tutto quello che comporta. C’è una canzone di Tom Petty che si chiama “Learning to fly” che dice “sto imparando a volare anche se so che non ho le ali”*** che descrive sì la parte dell’ascesa al successo, ma che la cosa più difficile è tornare a terra, perché nel momento in cui sei così in alto hai l’ansia che il successo possa finire.
**medici che, pur di far “star bene” i loro pazienti forniscono loro qualsiasi medicinale, stupefacenti inclusi
*** “I’m learning to fly, but I ain’t got wings” (Jeff Lynne / Tom Petty) dal disco “Into the great wide open” (1991)
Se potesse riportare in vita un artista per due ore, chi sceglierebbe?
Ce ne sono tanti, ma si dice che “il primo amore non si scorda mai”, giusto? Io riporterei in vita Jimi Hendrix, che è stato il mio idolo quando ero ragazzino, volevo essere lui, mia mamma cercava senza successo giacche con le frange, blue jeans con le toppe e tutte le cose che gli vedevo addosso, anche la chitarra. È stato, come ha detto Bono Vox una volta, “il più grande genio strumentale della storia del rock”. Nel caso di Hendrix, al di là di scoprire cosa è successo veramente, il vero delitto è quello di un ragazzo a 27 anni, un talento smisurato, molto avanti da tutti i punti di vista. La sua morte ci ha privato di tanta grande musica che sicuramente avrebbe fatto a modo suo, senza ripetersi, facendo magari sperimentazioni, collaborazioni: abbiamo soltanto tre dischi e un live ufficiale. È uno che fece la cover di “Sergent Pepper” dei Beatles dopo averla ascoltata in radio e la suonò davanti a loro tre giorni dopo l’uscita dell’album. Fece anche la cover di “All along the watchtower” di Bob Dylan e quando Dylan l’ha ascoltata non l’ha più suonata per almeno trent’anni, salvo riprenderla nella versione di Jimi come omaggio a lui, come se fosse diventato un pezzo suo. Questo per dire della stima che Jimi Hendrix ha sempre avuto, di cui ha sempre goduto da parte di colleghi e artisti amici. Poi era la quintessenza dell’Hippismo e della controcultura di quegli anni, un personaggio che mi ha sempre affascinato, da ragazzino ne vedevo solo alcuni aspetti superficiali, da adulto e da storico ho capito che per me era l’artista giusto.
Durante le ricerche e la stesura delle storie ha scoperto qualcosa che non sapeva?
Moltissime cose. La ricerca e le informazioni sono frutto di tantissimi anni di frequentazione, molti dei protagonisti dei racconti li ho conosciuti o li ho incontrati, e ho conosciuto molti soggetti del loro entourage: amici, colleghi di lavoro… Ci sono state ricerche bibliografiche e ricerche online e sono emerse tantissime informazioni. È stato impressionante sapere da James Taylor durante un’intervista che nel pomeriggio dell’8 dicembre 1970 a New York si era imbattuto casualmente, salendo le scale della metropolitana, in questo ragazzotto che poi scopre sarebbe stato l’assassino di John Lennon. Proviamo a pensare al concetto di sliding doors, pensiamo se lui, invece di aver fatto quello che chiunque avrebbe fatto, ovvero cercando di svicolare, gli avesse dato retta e l’avesse portato da John Lennon… magari non gli avrebbe sparato oppure avrebbe sparato a James Taylor, chi lo sa. Non so cosa abbia pensato James Taylor, ma quando me l’ha raccontato ancora riviveva quel momento. Riporto spesso questo episodio, James Taylor me l’ha raccontato probabilmente durante un’intervista su un suo nuovo disco, ma non ricordo come siamo finiti sull’argomento John Lennon. Di cose così me ne sono rimaste attaccate tantissime, molte di queste riportate nel libro. Anche la storia di Laurie Anderson e Lou Reed è molto toccante, qualcosa su cui ho riflettuto e anche una chiave sulla base della quale ho virato il libro. Lou Reed era un po’ lo spauracchio di tutti i giornalisti, uno molto ostico, quasi crudele, un personaggio tosto: ha cantato l’eroina, il lato selvaggio della vita, dei reietti, dei disgraziati. Laurie invece è una donna fantastica, un’artista creativa, ha lo sguardo che illumina, sorride sempre; mi sono sempre chiesto “ma come fanno a stare insieme?” Erano uno l’opposto dell’altro. Parlandone con lei dopo la morte di Lou, quando è venuta a promuovere un documentario dedicato alla loro cagnolina (“Heart of a dog”) – in cui si vedono alcune immagini di loro due – mi disse due cose, una è una frase che ho riportato, parlando della scomparsa del marito: “la morte può anche essere vista come una presa di coscienza, da parte di chi sopravvive, dell’amore che ha provato per la persona scomparsa, perché il dolore che provi è direttamente proporzionale all’amore che hai avuto per quella persona”. Sfruttando il fatto che ci conoscevamo le ho detto che non vedevo Lou alle prese con la cagnolina, ma lei mi ha risposto che non potevo capire quanto Lou fosse affettuoso, quanto adorasse quel cane e di come, con le sue cure, l’avesse portata a vivere altri quattro/cinque mesi. Questa cosa mi ha fatto capire che anche dietro a questi personaggi c’è un altro aspetto che viene fuori; nel racconto che Laurie fa degli ultimi giorni, la morte viene vissuta quasi in modo poetico. Questi episodi mi hanno orientato verso un tipo di narrazione che avrebbe potuto prendere in considerazione anche questo aspetto, laddove ci fosse stato.
Roberta Usardi