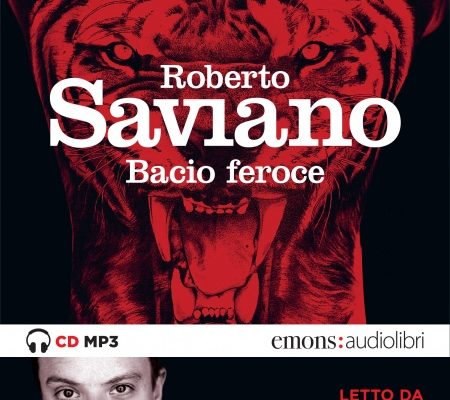A proposito di “Brevi interviste con uomini schifosi” di D. Wallace / D. Veronese

Entrano uno alla volta, nella penombra, togliendo le calzature prima di prendere posizione intorno al tavolo. Entrambi indossano una maglia nera a maniche lunghe e jeans blu, mentre tutte le superfici attorno a loro sono completamente bianche. Un respiro d’intesa, un colpo di campanello, si accendono le luci. Catapultati nel bel mezzo di una crisi di coppia, assistiamo al momento in cui un uomo (interpretato da Paolo Mazzarelli) sfrutta ogni espediente possibile, spingendosi fino alla più esplicita manipolazione emotiva, per tenere legata a sé la donna (Lino Musella) che ha intenzione di lasciarlo.
Inizia così la pièce Brevi interviste con uomini schifosi, tratta dall’omonima raccolta di David Foster Wallace (1999), in scena al Teatro Sanbàpolis di Trento il 9-10 marzo nell’ambito della Stagione Regionale contemporanea. Giunto in fin di ripresa, cioè al culmine del suo discorso, l’uomo fa scattare nuovamente il campanello. Scende il buio, una pagina di quaderno viene voltata, cambiano le posizioni e i ruoli; un cenno, uno squillo, un altro lui e un’altra lei. Il rito si riproporrà, con minime variazioni, fino all’ultima battuta. Perversi, opachi, velenosi, questi uomini hanno caratteri differenti ma appartengono alla medesima specie: sicuri di sé in modo quasi ossessivo, devoti soltanto al proprio ego, anche da nudi non potrebbero fare a meno dell’armatura di ipocrisie che protegge e nasconde le ferite (subite e inferte).
Sono – e qui non si può fare a meno di citare le parole con cui Fernanda Pivano introduceva l’edizione Einaudi (2000) – “storie di humor nero, con violentatori sessuali e faliti spirituali, nelle quali stupro e masturbazione si beffano dell’amore romantico, e gli affetti della famiglia sono messi a confronto coi danni che recano.” Un solo uomo, uno tra tutti, affronta l’incertezza e racconta alla sua interlocutrice un episodio esplicito di violenza, mettendo in rilievo non pochi stereotipi sull’argomento: un monologo molto duro e insieme molto delicato, che toglie letteralmente il fiato nel momento in cui il narratore viene a coincidere con la vittima.
Occorre però scindere la performance dei due attori dall’operazione svolta e diretta da Daniel Veronese: una drammaturgia a dir poco disarmante che iper-semplifica il capolavoro di Wallace (a partire dalla frantumazione dei personaggi femminili) e una regia che sembra girare a vuoto su se stessa.
Ora, adattare un libro al teatro vuol dire (al di là dei problemi legati alla traduzione) saper sciogliere e scegliere: delimitare il testo, decidere quanti nodi narrativi salvare o rompere (e a quale prezzo), dare un peso, uno scopo e un desiderio a ciascun elemento del racconto che ogni sera prenderà forma e vita davanti al pubblico. Sia chiaro, il grado di fedeltà al materiale di partenza non costituisce un criterio di giudizio valido, anzi l’autonomia e l’invenzione sono quanto di più prezioso nell’arte della messa in scena; d’altro canto, non ci si può nascondere dietro un dito se l’originalità della pièce si esaurisce in una formula (l’alternarsi nei ruoli maschili e femminili) applicata da cima a fondo e se la regia si affida pressoché totalmente alle qualità degli interpreti, per eccellenti che siano.
Pier Paolo Chini